Tra iperboliche eco mediatiche di un mercato a tutto mondo, la mostra di Warhol brilla al Palazzo Ducale.
Se vogliamo capire perché il nostro tempo è potentemente amorfo, superbamente potente, la mostra su Warhol e la Pop Society, al Palazzo Ducale di Genova sino al 26 febbraio 2017, curata da Luca Beatrice, non possiamo perderla.
La pop art è stata la pandemia del multiplo stonato che ci ha trascinato nel magma delirante del barocchetto digitale, genialmente compresso nel nostro deambulare quotidiano. Obesità da pixel puntinato, retinato, bulimia molto americana, troppo.
Andrew Warhola jr. nasce il 6 agosto 1928 a Pittsburgh. Si farà chiamare Andy Warhol:
un intellettuale, un artista, uno scrittore, fotografo o cineasta o, soltanto, scaltro businessman o, forse, anche cattivo serigrafo che inciampa su un fuori registro – normali fogli di scarto in ogni stamperia – e sa trovare il pozzo di petrolio?
Andy e i Trump
 Su Andy l’artista, una luce l’accende la giovane famiglia Trump, con un Donald così difficile e poco emulsionante verso lui da meritarsi l’aggettivo di persona “ordinaria”, e si pensi che soltanto alcuni mesi prima, nell’estate dell’81 in uno dei suoi accerchiamenti allo establishment ricco e famoso verso il quale il suo magazine Interview fungeva da testa di cuoio, Warhol definiva il biondo miliardario un bell’uomo.
Su Andy l’artista, una luce l’accende la giovane famiglia Trump, con un Donald così difficile e poco emulsionante verso lui da meritarsi l’aggettivo di persona “ordinaria”, e si pensi che soltanto alcuni mesi prima, nell’estate dell’81 in uno dei suoi accerchiamenti allo establishment ricco e famoso verso il quale il suo magazine Interview fungeva da testa di cuoio, Warhol definiva il biondo miliardario un bell’uomo.
Andy aveva lavorato molto producendo diversi “dipinti” nei toni del nero e dell’argento dedicati alla Trump Tower, pensati per il suo ingresso, ma i Trump ne restarono perplessi, la moglie inoltre ne fu contrariata perché i colori non si intonavano alle tappezzerie. Rimedierà, in seguito, ma non sappiamo con quanta efficacia, cercandosi le mazzette dei colori.
Andy era convinto che i Trump avrebbero capito l’importanza della sua opera d’arte dedicata al loro grattacielo-tempio tanto da dedicargli la copertina del catalogo. Sembrava una grande idea. Ma solo per Andy.
Questo è il senso che si rileva sfiorando appena quella che a mio avviso è l’opera più originale di Andy, i Diari (Istituto Geografico De Agostini, 1989), purtroppo molto poco celebrati forse perché la parte umanata è la parte vera, quella che si spinge oltre i ricchi e famosi, vip e arrivisti.
Ci sono anche “checche, lesbiche e amfetamine”, party e vernissage starlet, giovani artisti talentuosi, una cronaca della sua Factory argentata nella 47a e dell’America esaltante e al contempo deprimente sino alla terribilità di un colpo di pistola che quasi lo imbuca per il Creatore, esploso – si racconta – da 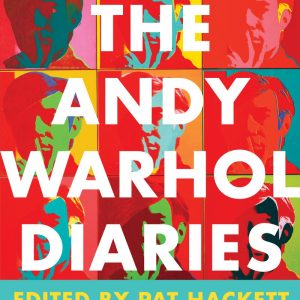 una “lesbica pazza” che frequentava la Factory per via dei suoi film underground.
una “lesbica pazza” che frequentava la Factory per via dei suoi film underground.
E qui, si sente il bisogno di rifugiarsi nella velocità delle arti descritte dal Vasari (inutile scomodare il Bellori, troppo colto) in cui troviamo quella densità oracolare che ci restituisce il sentiero per uscire dal buco nero dell’arte meccanica, impenetrabile e straziata, che a partire dagli anni sessanta ha mutato la società, come si osserva anche nelle intenzioni della mostra.
“Ma se la scrittura per essere in-colta e così naturale com’io favello, non è degna de lo orecchio di Vostra Eccellenzia, scusimi, che la penna d’un disegnatore non ha forza di linearli e d’ombreggiarli; si degni di gradire la mia semplice fatica, considerando che la necessità di procacciarmi i bisogni della vita non mi ha concesso che io mi eserciti con altro mai che col pennello.”
Teste, ritratti, mezze figure, accondiscendenti oppure su commissione, grandi sarti, industriali, cantanti pronti ad autoacquistarsi, superstar e miti capaci di sedurre il mercato, Greta, Mao, la Gioconda, Nicholson, Liz, Fiorucci, Armani, Versace, Travolta, Dylan, Elvis e, naturalmente, il nostro Agnelli.
Serigrafia iperbolica

Andy Warhol, Dollar Sign, 1981, acrilico e serigrafia su tela, cm 278 x 178. Nizza, Musee d’Art moderne
et d’Art contemporain, c The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc.by SIAE 2016, foto: c Muriel Anssens / Nizza
Poi simboli di ogni genere, commerciali, sociali, politici, pubblicitarie, sedie elettriche, falci e martelli, Coca Cola, dollari. Una produzione industriale di serigrafie in cui l’artista lasciava intendere troppe cose, persino un senso politico, impegnato, ma che è palesemente assente.
Di certo sappiamo che la sua firma apposta su un lavoro a stampa serigrafica, generata dalla fotomeccanica, supera strepitosamente, spudoratamente, di molto, di moltissimo il mercato di un Dürer, di un Rembrandt o di un Goya che sublimamente disegnavano e incidevano direttamente sulla lastra di metallo la loro unica e fragile matrice.
E qui ricordiamo Benjamin secondo cui la riproducibilità deve fare i conti con ciò che si definisce l’aura dell’opera d’arte. Qualcosa di irreperibile, presente nelle opere del passato, un valore che ne garantiva l’autenticità, proveniente da interventi tecnici non imitabili. L’opera limitata a pochi, che manteneva integro il suo valore per tutta la comunità e mai percepita come facsimile da ognuno.
Fenomeno elettronico di massa, invece, che zampilla dai nostri pori. Non che il nostro biondo scapigliato fosse privo di competenze artistiche, si deduce anche dalle sue illustrazioni nei libri in mostra. Le sue polaroid – notevoli, in mostra – venivano riprodotte su acetato e per essere compiacente con la committenza lavorava di fotoritocco, aggraziava
nasi, occhi, bocca, collo, l’immagine veniva poi ingrandita a 40 x 40 cm e quindi si procedeva alla serigrafia, si creava la mascheratura per la selezione dei colori: bocca, occhi, cravatte, giacche, contorni. Tutto veniva serigrafato in sovrapposizione alla foto oppure in fuori registro.

Andy Warhol, Liza Minnelli, 1978, serigrafia su tela, cm 101 x 101. Collezione privata, c The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc. by SIAE 2016, foto: c Cristina Leoncini
Questo era il tocco stregato che dava ai multipli di Andy specificità e folgorazione. In arte, tutto può accadere: se osserviamo gli artisti contemporanei più celebrati e le loro trovate, allora sì che Andy è un gigante. Gauguin sosteneva che le idee superano la tecnica e Warhol le idee le aveva, soprattutto su come gestire la sua rete di relazioni che arrivava molto in alto, su, su, sino ai Kennedy e al presidente degli States, Carter.
Pat Hackett, studentessa universitaria, cronista della Factory, avrebbe meritato il Pulitzer Prize for Fiction per aver reso possibile i Diari, tratti da ventimila pagine di appunti. Tutte le mattine ascoltava per ore il resoconto del giorno prima, incontri, amici, feste, spese, incassi. Andy teneva conto persino delle telefonate, ed era felice quando poteva usare il telefono degli altri. Pat non riceveva paga, forse il rimborso del bus, ma non è certo. Trascriveva, correggeva, migliorava il discorso. Andy detta i suoi Diari dalla fine del settantasei sino alla sua morte, il 22 febbraio 1987, per problemi alla cistifellea.
E ancora Vasari : “Ora che la fortuna mi promette pur tanto di favore, che con più commodità e con più lode mia e con più satisfazione altrui potrò forse così col pennello come anco con la penna spiegare al mondo i concetti miei qualunque si siano.”
Francesco Pirella – Genova, 31 dicembre 2016
Nella foto accanto al titolo: Una sala della mostra allestita al Palazzo Ducale nell’Appartamento del Doge








Scrivi un commento