L’amico Massimo Prati * ha fatto, da buon filologo qual è, delle interessanti riflessioni sull’evoluzione del linguaggio, che col suo permesso riportiamo in questo articolo, auspicando di aprire, come altre volte un dialogo tra i nostri lettori.
“Ho sentito l’estratto di un’intervista del papà della compianta Giulia Cecchettin [trasmessa a Chetempochefa – ndr] in cui diceva a Fabio Fazio che gli uomini, riferendosi alla propria moglie, alla propria fidanzata o alla propria compagna non dovrebbero dire «la mia donna». L’intento era buono. Il signor Cecchettin ha tutto il mio rispetto per il dolore che sta vivendo. Ma, il ragionamento – a parer mio – non era portato fino in fondo.
“Io sono molto d’accordo – prosegue Massimo Prati – con chi dice che bisogna fare attenzione al linguaggio, censurare vecchi termini e coniare neologismi. A volte il cosiddetto «politically correct» porta ad alcune esagerazioni. Ma, il principio di curare o rivedere il linguaggio e liberarlo da pregiudizi e vecchi schemi mentali è una innovazione positiva.
Siamo schiavi dei nostri limiti
Francis Bacon (1561 – 1626), nel «Novum Organum», scriveva «Perché gli uomini sono convinti che il loro intelletto governi le parole; ma è anche vero che le parole reagiscono sulla comprensione; ed è questo il motivo che ha reso sofistiche e inattive la filosofia e le scienze».
Noi usiamo le parole pensando di essere padroni supremi della lingua scritta e parlata, ma in realtà il linguaggio che scegliamo forgia la nostra mentalità e, a volte, le gabbie mentali che ne derivano ci impediscono di comprendere la realtà, così da padroni supremi ci troviamo a essere schiavi della nostra inadeguatezza, dei nostri limiti o della nostra impreparazione.
Avere o Essere?
È una mia lettura giovanile che risale a più di 40 anni fa e spero che la memoria non mi inganni ma, se non mi sbaglio, Erich Fromm in «Avere o Essere» faceva anche alcune riflessioni linguistiche sull’uso di questi due ausiliari, e sulle persone centrate più sull’uno o sull’altro ausiliare. Sono passati quasi cinquant’anni e da allora lo spazio del verbo «avere» ha guadagnato enormemente terreno nel linguaggio quotidiano, con tutto un corollario di termini mercantilistici che hanno invaso anche gli ambiti della cura e del sapere oltre che, ovviamente, quelli dell’economia e del lavoro.
Fateci caso: un presentatore o un uomo di spettacolo parlando dei propri ospiti, in un annuncio di poco precedente alla sua trasmissione, nove volte su dieci dirà «stasera abbiamo con noi…» e non «stasera saranno con noi…».
La vittima di un evento meteo estremo magari dirà «quest’anno abbiamo avuto l’alluvione» e non «quest’anno c’è stata l’alluvione».ma si può davvero “avere” un alluvione?
Piccoli indizi linguistici, dunque, che lasciano trasparire un maggior uso di “avere” a discapito di “essere”, un segno dei tempi. Un uso dei verbi ausiliari che quindi da un lato è rivelatore di una mentalità e dall’altro è catalizzatore di un pensiero dominante focalizzato appunto sull’Avere.
Se poi a questo aggiungiamo i “debiti formativi” al posto degli “esami di riparazione”, le “aziende ospedaliere” al posto degli “ospedali”, il “saper vendersi” al posto di “candidarsi” o “sapere proporsi”, direi che risulta chiaro come la logica da mercante ha condizionato il linguaggio in modo pervasivo.
Si vive solo il presente
Aggiungerei anche qualche riflessione sull’uso crescente del presente ai danni del futuro: “domani vado” anziché “domani andrò”. Altro segno dei tempi, di una società che rimuove il passato, non pensa al futuro e cerca di immergersi in un perenne presente. A me usare i verbi al futuro piace: mi fa apprezzare la differenza tra le cose che ho fatto e quelle che devo ancora realizzare.
Possedere o condividere?
Ora, dopo questa lunga premessa, volta a chiarire che la scelta delle parole è importante, torno sul ragionamento del Signor Cecchettin, per dire che l’intento della sua riflessione era buono ma il ragionamento non è stato portato alle più estreme e logiche conseguenze: il problema non è l’uso dei sostantivi «compagna», «moglie », «donna» ma quello dell’aggettivo possessivo «mia» che esprime appunto possesso o proprietà [una volta, rivolgendosi all’interlocutore si chiedeva “come sta la Sua signora?” oppure “mi saluti la Sua signora” non “sua moglie” – ndr].
Si dovrebbe educare le persone, e gli uomini in particolare, a dire eventualmente «è la donna della mia vita» perché, in quanto uomo, «la vita è mia» ma la «donna» o la «fidanzata» o la «compagna» no. Quindi uno dispone della propria vita, non di quella altrui. E quindi, non essendo «propria» la persona amata, forse è possibile che non sia la donna o la compagna dell’intera vita. Magari si farà anche una parte di vita da soli, oppure si troverà una nuova compagna. Se invece si passerà l’intera vita insieme felici e contenti con la propria compagna, allora tanto meglio.
Comunque, per me [MassimoPrati], l’espressione apparentemente romantica e amorosa e orribilmente alienante è sentire un uomo parlare dell’amore per una donna e, riferendosi a lei, dire: «è la cosa più bella che ho» [che equivale orribilmente a dire: che possiedo – ndr].
Primo perché non si tratta di una cosa e poi perché non se ne ha la proprietà.
Un primo commento ricevuto si fa riferimento a un romanzo di Chaim Potok “Il mio nome è Ascher Lev ” in cui c’è un dialogo bellissimo tra il protagonista Ascher e suo Padre all’uscita dalla Sinagoga. Ascher nota un passerotto morto per strada e rimane turbato e chiede al Padre perché è morto, il Padre gli dice che tutte le creature dell’universo un giorno moriranno, compreso lui, la Mamma e anche tu Ascher. A quel punto Ascher ripete “Perché” e il Padre risponde : “è così che vuole Dio per far sí che amiamo le persone a noi care, mentre qualcosa che sai essere tua per sempre non puoi amarla“. Questo per far capire che la Persona che ami non è di tua proprietà e devi conquistarla giorno dopo giorno, con il rispetto e la fiducia non incatenandola; e lasciandola andare se vorrà andare.
Sono graditi altri commenti.
* Massimo Prati, è nato a Genova dove si è laureato in lingue e letterature straniere; filologo, oggi insegna a Ginevra. Quando può torna a Genova a vedere, tra la altre belle cose, le partire della sua squadra del cuore, ovviamente con maglia rossoblu, di cui è anche uno storico affermato della squadra e dei pionieri del calcio, su cui ha pubbblicato vari libri, in Italia e in Svizzera.






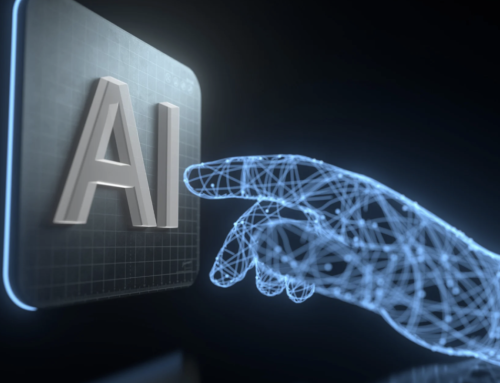

Scrivi un commento